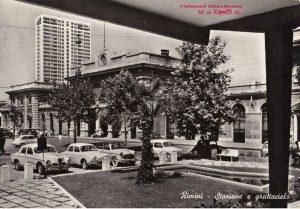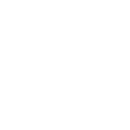Così scriveva Giovanni Pascoli (romagnolo doc), parlando della sua terra. Della nostra, anzi.
Ed è sicuramente emozionante.
In questo duro periodo che, purtroppo, rimarrà nella storia e verrà probabilmente studiato sui libri dai nostri nipoti, noi di Rimini e della Romagna tutta sentiamo forte quella fitta allo stomaco che ci pervade.
Una fitta che ci prende perché chi “fa la stagione” sa bene che il momento è difficile e non si sa come né quando uscirne fuori.
Noi non siamo statisti, non siamo economisti, non siamo virologi ma siamo persone appassionate del proprio lavoro e amanti della propria terra.
Ci occupiamo e lavoriamo con il turismo: sappiamo bene quanto bello sia il mondo.
Però, in questa fase, abbiamo abbracciato l’idea di voler stare a casa, in tutti i sensi. Se l’unione fa la forza, è il momento di unirci!
Nessun boicottaggio e nessun complotto: ciò che faremo sarà solo incentivare il turismo nazionale aiutando le imprese italiane a risollevarsi.
Forza Romagna, siamo con te! #iorestoinitalia
Ecco la poesia di Pascoli al completo
Romagna
a Severino
Sempre un villaggio, sempre una campagna
mi ride al cuore (o piange), Severino:
il paese ove, andando, ci accompagna
l’azzurra visïon di San Marino:
sempre mi torna al cuore il mio paese
cui regnarono Guidi e Malatesta,
cui tenne pure il Passator cortese,
re della strada, re della foresta.
Là nelle stoppie dove singhiozzando
va la tacchina con l’altrui covata,
presso gli stagni lustreggianti, quando
lenta vi guazza l’anatra iridata,
oh! fossi io teco; e perderci nel verde,
e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie,
gettarci l’urlo che lungi si perde
dentro il meridïano ozio dell’aie;
mentre il villano pone dalle spalle
gobbe la ronca e afferra la scodella,
e ’l bue rumina nelle opache stalle
la sua laborïosa lupinella.
Da’ borghi sparsi le campane in tanto
si rincorron coi lor gridi argentini:
chiamano al rezzo, alla quiete, al santo
desco fiorito d’occhi di bambini.
Già m’accoglieva in quelle ore bruciate
sotto ombrello di trine una mimosa,
che fiorìa la mia casa ai dì d’estate
co’ suoi pennacchi di color di rosa;
e s’abbracciava per lo sgretolato
muro un folto rosaio a un gelsomino;
guardava il tutto un pioppo alto e slanciato,
chiassoso a giorni come un biricchino.
Era il mio nido: dove, immobilmente,
io galoppava con Guidon Selvaggio
e con Astolfo; o mi vedea presente
l’imperatore nell’eremitaggio.
E mentre aereo mi poneva in via
con l’ippogrifo pel sognato alone,
o risonava nella stanza mia
muta il dettare di Napoleone;
udia tra i fieni allora allor falciati
de’ grilli il verso che perpetuo trema,
udiva dalle rane dei fossati
un lungo interminabile poema.
E lunghi, e interminati, erano quelli
ch’io meditai, mirabili a sognare:
stormir di frondi, cinguettìo d’uccelli,
risa di donne, strepito di mare.
Ma da quel nido, rondini tardive,
tutti tutti migrammo un giorno nero:
io, la mia patria or è dove si vive:
gli altri son poco lungi; in cimitero.
Così più non verrò per la calura
tra que’ tuoi polverosi biancospini,
ch’io non ritrovi nella mia verzura
del cuculo ozïoso i piccolini,
Romagna solatìa, dolce paese,
cui regnarono Guidi e Malatesta;
cui tenne pure il Passator cortese,
re della strada, re della foresta.