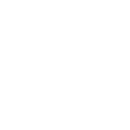Si era appena usciti dall’oscuro tunnel della guerra, ma lo scenario che si presentava lasciava sgomenti i sopravvissuti: ovunque erano macerie, distruzione e crateri di bombe.
Molte case del Borgo, già di loro annerite e scrostate da secoli di esistenza, erano semidistrutte ed anche quelle miracolosamente rimaste in piedi sembravano teschi dissepolti e anneriti dal tempo, con orbite prive di occhi.
Gli scuri delle finestre, infatti, nei primi giorni dopo il passaggio del fronte, erano stati asportati dai proprietari o rubati per finire come legna da ardere, per riscaldare le misere case di coloro che erano ritornati ad abitarvi.
I rigogliosi pini di via Matteotti, ogni giorno di più, venivano spogliati dei loro rami ed alcuni tagliati alla base. “La Cesa ad San Zulien”, “la rutonda de pret”, “e palaz dagl’aquili”, “al scoli Decioragi”, non erano distrutti anche se mostravano notevoli ferite all’esterno.
Praticamente intatti all’estremità del Borgo i palazzi Mazza e Pari, in stile architettonico del ventennio, in fregio ai quali vi è tuttora la minipineta triangolare (i zardinett), splendido biglietto di presentazione della città di Rimini per chi giungeva dal settentrione percorrendo la via Emilia o la via Popilia. “E pount ad fer” era stato ripristinato dal genio militare alleato.
Rimaneva interrotta la passerella pedonale in ferro che correva ad esso adiacente. Era la via più breve per chi a piedi voleva recarsi dal Borgo alla” Paleda longa”, al “Grandotel”, alla “spiagia di sgnur”, le zone più belle ed eleganti della Rimini turistica. Quel passaggio aveva per me un fascino particolare. Sento ancora il rimbombo metallico provocato dagli zoccoli sbattuti con forza sul piano in ferro sbalzato in un silenzio che oggi sembrerebbe irreale.
Guardavo l’acqua chiara, pulita, scorrere in basso fra lingue di bianca ghiaia e sabbia azzurrognola. Giungeva fino a quel luogo, nelle giornate estive, il profumo del mare spinto da una brezza leggera che faceva schioccare le vele multicolori, aperte o amanticiedi, delle tante barche ormeggiate alle banchine del porto. Ho sempre sperato che quel cammino fosse ripristinato, ma purtroppo ciò non è avvenuto.
L’arcata sud del Ponte dei Mille era crollata e il manto stradale, spezzato in due parti in modo netto, formava una V allargata immersa nell’acqua del fiume. Sopra era stato gettato un ponte militare di ferro.
Alcuni ragazzi avevano legato alla struttura del nuovo ponte una lunga cima di barca e lanciandosi nel vuoto, appesi ad essa, come fosse una liana, si divertivano ad imitare Tarzan (Erano arrivati i primi film americani non ancora doppiati). Maestri in questa esibizione erano i due fratelli Pasquini. Ricordo che ogni loro volo era accompagnato da un urlato “Caaaamba” che doveva essere un “caramba “, ma non avendo entrambi la capacità di pronunciare la erre, in tale modo si esprimevano.
Un giorno la vecchia fune si ruppe e mentre il grido di guerra si fermò a “caaa..”, uno dei fratelli, quello con la chioma rosso fuoco, precipitò in acqua completamente vestito con l’“aamba ”rimasta in gola, fra le risate generali e le sonore pernacchie di chi assisteva alla coraggiosa esibizione. Il Ponte di Tiberio, mai colpito dalle bombe degli alleati, aveva resistito anche alle cariche esplosive dei Tedeschi in ritirata.
L’unico danno che aveva subito era la rottura di uno dei lastroni di pietra d’Istria della pavimentazione. Non era stato reciso il cordone ombelicale che univa da quasi due millenni il nostro Borgo alla città di Rimini!
La vita della comunità del Borgo alacremente riprendeva. L’arte di arrangiarsi non era solo prerogativa, come spesso si dice, degli abitanti del meridione. Così ripartivano tante attività artigianali e commerciali legate alla vita del mare e non. Pochi ricordano che la ripresa del turismo, anzi della villeggiatura, come si diceva allora, è passata anche attraverso l’iniziativa e l’intraprendenza di molte famiglie del Borgo.
Non esisteva nessuna forma di pubblicità o di promozione; funzionava il passaparola, la lettera e la cartolina postale. La domanda, se pur limitata, superava l’offerta e così cominciavano a giungere nella nostra città, soprattutto in primavera, centinaia di persone in cerca di camere o appartamenti da affittare per il periodo estivo.
Con il passare degli anni le poche centinaia diventeranno una moltitudine!
Le pretese di comodità dei villeggianti non erano eccessive e la qualità dell’offerta di allora non era certo elevata. Anche mia nonna, che abitava nell’ultima casa della via Marecchia vicino alla Chiesa della Madonna della Scala, aveva ricevuto, una domenica della primavera de 1946, la visita di una distinta signora bolognese accompagnata dal marito, la quale chiedeva di affittare una camera più l’uso di cucina per l’imminente periodo estivo.
Le trattative si erano svolte in modo concitato e in tempi non brevi!
Il piacere di mia nonna era stato il mostrare le comodità che la casa offriva; in primo luogo l’ottomana (così si chiamava allora il divano: la lutumena) in bella mostra in tla saletta, con la sua grande coperta a fiori sgargianti distesa sopra, la luminosa camera messa a disposizione e la cucina grande, ben fornita di suppellettili.
Ma il vanto più grande era il poter indicare nel cortile, sotto il pergolato, fissato al muro di sostegno della porta Gervasona, il gabinetto (la latreina), protetta alla vista da una fitta paratia di canne (la canezza).
Di fianco a questo servizio vi era un ricco pollaio, una grande conigliera e più in basso, recintato, un rigoglioso orto degradante verso il fiume fino ad esserne da questo lambito.
Completava e migliorava il tutto la presenza, a pochi passi dalla porta esterna della cucina, una magnifica fontana a pompa da cui sgorgava una fresca acqua ferruginosa che aveva tinto di rosso cupo lo scolo in cemento che arrivava fino al confine dell’orto.
Questo era un lusso di pochi all’epoca e nel Borgo: quasi l’acqua corrente in casa!
Mentre il marito si fermava ad ammirare la porta settecentesca e il bel torrione malatestiano, la signora era uscita per osservare meglio la poumpa dl’aqua, e mia nonna la seguiva con stampato sul volto uno stato di non completa soddisfazione.
Erano passati pochi istanti quando si sentiva un grido disperato: “ODDIO… GLI ESCREMENTI!”
La signora aveva notato che lo scolo del pollaio e della conigliera (l’uriol) correva parallelo e vicino a quello della fontana. In quel canaletto scendevano, infatti, i residui dei lavaggi dei due ricoveri per gli animali allevati e del rudimentale gabinetto. (Per dila scietta… spess i stagneva in cl’uriol brod e garneli).
Il disappunto della signora era forse determinato dalla preoccupazione che quei residui organici potessero inquinare l’acqua della fontana!
E in quel momento nasceva un grosso equivoco: quella esclamazione e la parola escrementi, mai udita prima, erano sembrate a mia nonna una ulteriore richiesta a suo danno.
Col piglio tipico della vecchia borghigiana nei momenti di collera, le gambe divaricate, mani poggiate sui fianchi e la voce alterata mia nonna si rivolgeva alla signora bolognese con queste parole: “Chera la mi sgnora…, adess basta! Aj’ ho calè e prez…, aj’ ho prumess la querta bona se let…, aj’ ho dett cla puteva rizev tla saletta e druvè la lutumena…, aj’ ho prumess una galeina per fè e brod a Ferragost…, aj’ ho dett cla puteva coj tott i dè l’insaleda tl’ort…, ma… se proprie la vò enca i… SCRIMENTI… quì chi lè… bsegna cla si porta da chesa sua!”.
E con questa sentenza si concludeva la difficile e lunga trattativa.
Sergio Serafini