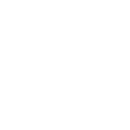Mazapégul
Il Mazapégul è un folletto tipico. Trattasi di un piccolo animale: può apparire come un gatto, uno scimmiotto o un coniglietto.
Fate
La narrazione popolare romagnola dedica ampio spazio agli esseri fatati.
Nel 1927 Uno Nino Massaroli pubblicò uno studio: Diavoli, diavolesse e diavolerie in Romagna che rappresenta quasi sempre la fata,
«quale fiorisce nelle novelle del focolare romagnolo, sotto forma di una veccia-vecchina; pulita, linda, dall’aria casalinga e simpatica di nonnina (…) Essa ha un preciso e gentile incarico, un esatto compito: disfare i malefici delle streghe; difendere le creature prese di mira dai geni del male, dai mostri della notte (…) Le fatine romagnole amano mostrarsi sotto forme piccolissime (…) La fata romagnola abita nella cappa del camino, sulla quercia dell’aia, nei pignattini del pagliaio»
(il pagliaio romagnolo s’erge sull’aia a forma conica retto da un’asta interna, sulla cui cima viene p osto un orinale o un pignattino per scongiurare le streghe).
Queste fate hanno un ruolo protettivo, specialmente nei confronti dei neonati. Era necessario svolgere rituali scaramantici per ingraziarsele, quali offrire pani bianchi o rosate focacce (…) durante il loro passaggio (che, in base alle diverse zone dell’Alpe di Romagna, avveniva alla vigilia dei morti, durante la notte di Natale o dell’Epifania).
Un altro esempio era la recitazione delle paròl faldédi (parole fatate) e formule d’invocazione le quali, nella Romagna toscana, atte a propiziarsi la fata del mattino nel mettersi in viaggio e sono rimaste attuali per i fanciulli romagnoli:
Turana, Turana – Rispondi a chi ti chiama – Di beltà sei regina – del cielo e della terra – di felicità e di buon cuore.
Alle fate è anche dedicato un racconto ambientato nelle colline fra Castrocaro e Faenza:
«Sotto Monte Sassone, accanto ai ruderi del castello della Pré Mora (Pietra Mora), nel banco dello spungone sullo strapìombo della voragine del rio della Samoggia, fra le colline a monte di Faenza e Castrocaro nella zona di demarcazione dell’antico confine fra la terra del Papa e quella del Granducato, sono scavate le quattro grotte delle fate (chiamate anche busa – buca – e camaraz – cameraccie). Questa pietra era un prodigioso palazzo, nei lontani millenni delle Fate che lo disertarono quando l’uomo non credette più alla poesia, ma vi lasciarono, pegno del ritorno, i loro magici telai d’oro, su cui l’anima tesseva le canzoni che nessuno sa più! E perché l’uomo non ne facesse sua preda, confidarono la guardia dei telai a un biscione che sibila minacce e con un soffio precipita nella voragine le ladre scalate, quando mai tentassero le porte inviolabili.»
- L. de Nardis, La Piê, 1925
Ségavëcia (Segavecchia)
Ovverossia il giovedì di mezza Quaresima.
Secondo la leggenda, una donna quel dì non rispettò l’astinenza dalla carne, mangiando un salsicciotto. Questo le valse una condanna a morte per stregoneria, che la volle giustiziata (il che si spiega poiché, all’epoca, il giovedì di mezza Quaresima era dedicato alla penitenza e al digiuno).
I tempi sono cambiati e le occasioni di penitenza si sono trasformate in feste: la vëcia da sghè viene segata nella piazza del paese e dal suo ventre capiente escono giocattoli e dolci.
Questa usanza ha attirato l’attenzione di diversi antropologi, i quali hanno fornito una spiegazione che prescinde dai racconti tradizionali.
- Secondo Renato Cortesi, che identifica con il nome “vecchia” l’ultimo covone mietuto, il nome sta a significare il “rito del sacrificio dell’ultimo covone”. Al termine della mietitura si eseguiva un rito per placare il risentimento della preziosa pianta, che era stata “violata”.
Dalle ultime spighe mietute si realizzava un fantoccio per poi procedere con il rituale: il simulacro veniva onorato, quindi distrutto. Il gesto appartiene agli antichi riti legati alla terra: il termine “vecchia”, infatti, è attestato in antropologia come riferimento all’ultimo covone in parecchie culture; il verbo “mietere” diventa, in romagnolo, sghè (“segare”); l’evoluzione ha portato allo stravolgimento della locuzione, da “mietere l’ultimo covone” a “segare la vecchia”.
- Baldini e Bellosi descrivono la Vecchia come simbolo della Terra la quale si riapre e si prepara a produrre i suoi frutti dopo la gelata invernale. Lo squarcio prodotto nel ventre della Vecchia
“prelude e stimola il parto della terra, gravida dei futuri frutti e raccolti”
Le feste della Segavecchia più rinomate in Romagna avvengono a Forlimpopoli e a Cotignola.
La “Vecchia” è anche la maschera romagnola del Carnevale.
Piligrèna
La Piligrèna (o Lôma o Lumèta) è il nome con cui ci si riferisce ai fuochi fatui (“da poco”, di apparenza ma di scarsa consistenza).
Nell’antichità si consideravano fenomeni misteriosi, ritenendoli una manifestazione della potenza magica della terra.
Stando a una credenza ancestrale, infatti, la terra è «viva» e detiene il potere di resuscitare.
A tal proposito queste manifestazioni luminose venivano associate a “povere anime” che per espiare le loro colpe vagavano senza pace oppure a defunti implacati che andavano in cerca di una degna sepoltura.
Un’altra funzione della Piligrèna è leggermente più macabra: veniva utilizzata per spaventare i bambini acciocché non si recassero al cimitero di notte, a sfidare i morti. Tipo delle madri ammonirli:
Sta ‘tenti ch’la j è la piligrèna c’at ciàpa!.
Altri esseri fantastici
… e dove trovarli! Eccone ancora qualcuno:
- la borda (spettro, spauracchio per i bambini),
- e’ papon (l’orco che mangia i bambini),
- l’om d’e’ sach (l’uomo che mette nel sacco i bimbi cattivi),
- la mort imbariéga (macabro personaggio che impersonifica la morte). A Faenza viene soprannominata la Jacmèna (“la Giacomina”) ed è identificata con un monumento funebre conservato nel Duomo,
- la Vècja, figura bonaria che vuole bene ai fanciulli.